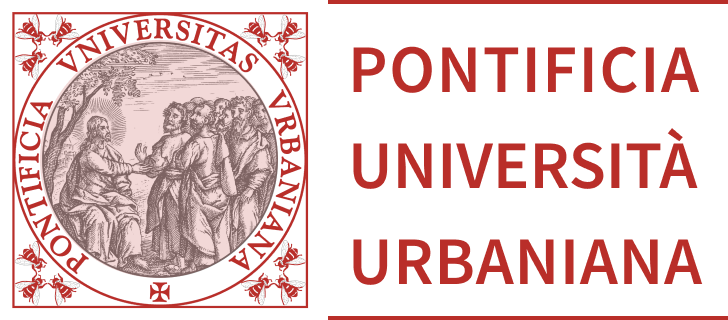Si è appena conclusa la Giornata di Studio sulle Radici Bibliche della Speranza promossa dalla Facoltà di Teologia della Pontificia Università Urbaniana
La Giornata di Studio sulle Radici Bibliche della Speranza all'Urbaniana
La Giornata di Studio sulle Origini Bibliche della Speranza è parte integrante del ciclo di conferenze promosse dalla Facoltà di Teologia della Pontificia Unieversità Urbaniana, come la recente Giornata di Studio sul Concilio di Nicea.
L'evento è stato seguito sia in presenza sia in online, per favorire la partecipazione anche di tutti gli interessati dagli istituti affiliati all'Università Urbaniana, dislocati in diverse parti del mondo: un'occasione di studio, approfondimento e comunione allo stesso tempo.
Giornata di Studio sulle Radici Bibliche della Speranza
“Dov’è la mia speranza?” (Gb 17,15)
Le radici bibliche della speranza
Conclusioni
a cura del Prof. A. Landi
Docente Consociato di Sacra Scrittura – PUU
Lo scopo di un Convegno è di aprire piste di riflessione che dispieghino nuovi orizzonti di senso sul tema affrontato; pertanto, le conclusioni non devono dare la sensazione di “sentieri interrotti” di memoria heideggeriana, ma la certezza che, quanto comunicato dai nostri relatori e dibattuto in aula, rappresenti un’àncora, riprendendo l’immagine di Eb 6,19 evocata da mons. Fisichella e dal prof. Grilli, alla quale volgere lo sguardo come fermo punto di partenza.
«La speranza è un rischio da correre. È addirittura il rischio dei rischi»: è una frase dello scrittore francese Georges Bernanos che ben sintetizza il concetto di speranza. Più volte è stato sottolineato che l’umanità del XXI secolo è a un bivio: o decide d’imporsi stili di vita ispirati alla sobrietà e alla parsimonia per quanto attiene lo sfruttamento delle risorse primarie e l’impegno a ridurre in maniera significativa la povertà e la corsa agli armamenti, o corre il rischio d’implodere.
In uno scenario politico, culturale e sociale così complesso c’è ancora motivo per attendere un futuro differente? Qual è il contributo che le religioni, il cristianesimo e, in particolare, la teologia possono offrire alla realizzazione di una società più attenta a non sciupare il patrimonio del creato a sua disposizione; più solidale e fraterna verso i poveri e gli emarginati; e meno avida di fama e onore a qualunque prezzo?
È doverosa la gratitudine ai relatori intervenuti, S.E. Mons. Rino Fisichella, sr. Elizangela Chaves Dias e don Massimo Grilli, per aver accolto l’invito della PUU e per aver declinato con competizione e passione il tema affidato a ciascuno di loro. In particolare, la panoramica proposta da mons. Fisichella sulle speranze della cultura contemporanea ha consentito di esercitare un diligente auditus mundi e di rilevare le fragilità e le potenzialità di un’umanità alla ricerca di senso e compimento. La speranza cristiana non è solo proiezione verso il futuro, ma è stabile radicamento nel tempo presente, basato sulla fede e sulla carità che in Cristo hanno origine e modello.
Nella relazione della prof.ssa Chaves Dias la principale chiave di lettura è stata la “pedagogia della speranza”: ella ha mostrato con un’interpretazione sapiente come nel libro del profeta Osea si assista al passaggio dalla punizione divina, prevista per l’infedeltà del popolo, alla “pedagogia della speranza” che presuppone la conoscenza intima del Signore. E così la valle di Acor, che significa “disperazione”, diventa, grazie alla compassione divina, “porta della speranza”, che può essere attraversata da chi confida nel Signore.
Infine, il prof. Grilli ha individuato tre tratti peculiari che connotano il tema della speranza nella letteratura del Nuovo Testamento: anzitutto, essa non può essere compresa nella dialettica promessa-adempimento che caratterizza il rapporto tra il Primo e il Secondo Testamento; inoltre, la speranza non si configura come una fuga verso un aldilà astorico e disincarnato, perché si radica nell’esperienza del limite che costituisce la storia umana e gli esseri che la vivono. Infine, la speranza, così come scrive l’apostolo Paolo in Rm 5,5, non delude, perché consegna all’uomo la possibilità di essere riconciliato e redento.
È in tale contesto che la speranza cristiana può essere apprezzata, ancora oggi, nel suo potenziale “sovversivo”: in effetti, osare sperare non un mondo, ma un modo diverso di concepire la
realtà può essere ritenuto un atto trasgressivo, una proposta controcorrente che imprime
una sterzata alla sete di auto-affermazione dell’homo Deus (Yuval Noah Harari, storico e filosofo israeliano), che ha detronizzato Dio divinizzando se stesso. È l’uomo che non ha bisogno di Dio, perché si è sostituito ad esso erigendosi ad arbitro del bene e del male.
Denunciando la «dittatura del relativismo», il cardinale Joseph Ratzinger, futuro papa Benedetto XVI, nell’omelia pronunciata in occasione della Missa pro eligendo Romano Pontifice (18 aprile 2005) sosteneva che per i cristiani il criterio di giudizio non è il singolo individuo, ma «il Figlio di Dio, il vero uomo. È lui la misura del vero umanesimo. “Adulta” non è una fede che segue le onde della moda e l’ultima novità; adulta e matura è una fede profondamente radicata nell’amicizia con Cristo. È quest’amicizia che ci apre a tutto ciò che è buono e ci dona il criterio per discernere tra vero e falso, tra inganno e verità. Questa fede adulta dobbiamo maturare, a questa fede dobbiamo guidare il gregge di Cristo. Ed è questa fede - solo la fede - che crea unità e si realizza nella carità».
Sarà papa Benedetto XVI, appena due anni dopo la sua elezione, a firmare la lettera enciclica Spe salvi (30 novembre 2007) sulla speranza cristiana; al n. 27 si legge:
«la vera, grande speranza dell’uomo, che resiste nonostante tutte le delusioni, può essere solo Dio – il Dio che ci ha amati e ci ama tuttora “sino alla fine”, “fino al pieno compimento”» (cf. Gv 13,1; 19,30).
La speranza cristiana poggia sul saldo fondamento della fede, che è relazione vitale con
il Dio fedele e affidabile. Il teologo riformato Jurgen Moltmann, scomparso il 3 giugno 2024, ha rilevato che «in nessun’altra religione del mondo si lega Dio alla speranza del futuro»: il futuro dell’umanità è nelle mani sicure di chi le ha dato origine e ne assicura il compimento.
Tale orizzonte non resta precluso a chi è agnostico oppure ateo; Dio non è un’evidenza da dimostrare, ma una promessa che si adempie, una presenza che colma il vuoto e la solitudine di chi cerca un senso che appaghi l’esistenza. È la voce che squarcia il silenzio, la luce che brilla nelle tenebre; è trasformazione di una “valle di afflizione” in una “porta di speranza”, come ha ben mostrato la prof.ssa Chaves Dias.
La speranza cristiana non è attesa di qualcosa di nuovo, ma è disponibilità ad accogliere chi fa «nuove tutte le cose» (Ap 21,5); è prendere coscienza di essere attesi, non al varco per essere giudicati e condannati, ma alla soglia della vita eterna per essere riconciliati e redenti. Il futuro non è totalmente incognito e misterioso, da decifrare grazie all’ausilio della cartomanzia o all’intelligenze artificiale; è nelle mani di Dio e da lui possiamo attenderlo come dono che si rivela progressivamente lungo il corso della vita.
Desidero non concludere, ma aprire un ulteriore cantiere di riflessione con le parole poetiche e profetiche di fra’ David Maria Turoldo che invitano i credenti a sperare senza indugiare, ad amare e a lavorare per la pace, così come ci è stato chiesto da papa Leone XIV.
Voi che credete
voi che sperate
correte su tutte le strade, le piazze
a svelare il grande segreto…
Andate a dire ai quattro venti
che la notte passa
che tutto ha un senso
che le guerre finiscono
che la storia ha uno sbocco
che l’amore alla fine vincerà l’oblio
e la vita sconfiggerà la morte.
Voi che l’avete intuito per grazia
continuate il cammino
spargete la vostra gioia
continuate a dire
che la speranza non ha confini.